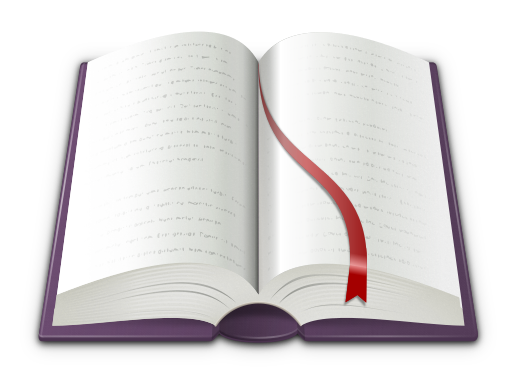- SOGNARE, FORSE
“Svegliati, amore, è scoppiata la guerra!”
Mentre affioravo dalle profondità degli ultimi minuti di sonno, prima del consueto suono della sveglia, il grido mi era parso lontanissimo, attutito.
La metropolitana mi stava cullando come ogni mattina, il libro aperto davanti mi offriva il perfetto rifugio dalla popolata indifferenza diffusa nella carrozza. Un segnale mentale inconscio mi aveva suggerito di controllare a che stazione fossi arrivato, consiglio che solitamente seguivo con diligenza o con riluttanza, a seconda di ciò che stavo leggendo. La memoria visiva fotografa Amendola in caratteri bianchi in alto sui muri della stazione. Il realizzare di stare viaggiando nella direzione sbagliata non mi procurato allarmi, ma solo un irritato pensiero alla lora e alla sua arcinota concha, imprecazione contagiatami dagli amici argentini che ci trovavamo molto spesso a frequentare. “Ho sbagliato ancora linea, cazzo, in questi giorni non ne azzecco una”. Solo un istante di isterico nervosismo milanese, per realizzare subito l’impossibilità di quel che mi stava accadendo: all’andata non posso sbagliare linea. La mia metropolitana si biforca al ritorno, all’andata corre diretta verso il centro. Mentre rifletto affiora alla mente un altro dettaglio: di fianco ad AMENDOLAspicca un altro cartello bianco con scritto qualcosa che non avevo afferrato. Mentre risollevo lo sguardo per leggerlo nuovamente, una voce annuncia che il treno termina la corsa; la folla scende, qualcuno impreca: “Non è possibile, ancora, tutte le mattine, ma dove stiamo andando a finire”. La voce insiste: “Il treno termina la corsa. Siamo sotto attacco. Chi è disposto ad arruolarsi come volontario nella resistenza può restare, gli altri sono invitati a uscire dalla stazione”. “AMENDOLA-ARRUOLAMENTO”, ecco che cosa c’era scritto. Assurdo. Imprigionato tra la folla che mi spintona, che si divide, che cerca di uscire, mi chiedo se debba andare ad arruolarmi. Ma contro chi poi? E’ una situazione insensata: esco all’aperto, dove su un lungo vialone, a me stranamente sconosciuto, camminano sparuti gruppi di persone, probabilmente emersi anche loro dalla metropolitana. Dopo un paio di chilometri mi fermo al primo raduno, in una fabbrica che pare abbandonata, pur essendo nuovissima. Mi siedo per riposare. Accanto a me gli scampati alla metropolitana si comunicano le teorie più strampalate sull’invasione in corso. Tutto sembra avvolgersi sempre più in una nuvola di assurdità, e quindi devo avere fiducia in un chiarimento e in una soluzione rapida. Le urla concitate mi riportano alla realtà: non si tratta di un’esercitazione, o della provocazione inscenata di qualche agenzia pubblicitaria, e nemmeno dell’azione di un commando terroristico ben organizzato. L’attacco c’è veramente e noi ci troviamo nel mezzo, anzi, proprio sopra. E’ iniziato un bombardamento da sotto terra, posso vedere, dagli oblò di vetro collocati sul pavimento, il rosso delle esplosioni. Trovarsi sotto un bombardamento deve essere terribile, ma esservici sopra crea una sensazione di terrore paralizzante: da un momento all’altro ti si può squarciare la terra sotto i piedi. Scappiamo, corro senza una meta, appena trovo una struttura metallica mi ci arrampico sopra. Coloratissima, sembra una giostra, o una costruzione del meccano. Non c’è tempo per chiedersi di che cosa si tratti, salgo, altri mi seguono. Improvvisamente, come se fosse stata avviata da qualcuno, la struttura inizia a muoversi. Enormi ganci, come quelli di una gru, colorate chele metalliche si aprono e chiudono: chi le ha azionate? Qualcuno cerca di saltare verso il basso, urla chi è rimasto sotto, grida impazzito chi è intrappolato nella struttura. Corro verso l’alto, ma mi trovo un gancio di fronte, non posso evitarlo, tra pochi istanti verrò stritolato. La struttura si blocca: qualcuno, disattivandola, mi ha salvato la vita, guardo verso il basso, chi sarà stato, che cosa sarà successo?
“Svegliati!”.
La guerra? Da anni, da decenni la guerra è permanente. Altrove.
“Ma hai sentito? Siamo in guerra!” mi urlò Lena.
Seduto sul letto, la osservo incredulo, con un brivido di stordimento e un confuso terrore addosso, ancora incerto, nel dubbio che sia impazzita.
“In guerra…con chi…da quando?”.
“L’Europa, l’Unione Europea, ha dichiarato guerra, il parlamento italiano non ha ancora votato, ma lo farà nei prossimi giorni. Stanno già bombardando. Questa volta ci siamo dentro anche noi”.
Non ritrovavo gli occhi appassionati di quando, con un’energia e una partecipazione che non provavo più da anni, mi illustrava instancabilmente le sue idee, le sue teorie sulla situazione politica internazionale, o mi raccontava di un corteo, un blocco stradale, una carica poliziesca. Non c’era l’orrore per i bombardamenti periodici dell’esercito israeliano sui palestinesi, o la rabbia per qualche studente o leader contadino latinoamericano trovato in una fossa comune. C’era qualcosa di sconosciuto: la voglia di reagire mentre un terrore irrazionale si sta facendo strada.
Eravamo sposati da quasi vent’anni e improvvisamente non riconoscevo più nulla di lei nel mio amplissimo catalogo mentale delle sue espressioni.
La televisione, che solo ora riconoscevo in sottofondo, reiterava immagini e notizie inutili. Prendevano tempo, in attesa di direttive superiori. Inviati con l’elmetto cercavano di far credere di avere più notizie dei giornalisti in studio. La versione ufficiale era confezionata sull’imprescindibile necessità di sferrare un attacco preventivo perché il feroce satrapo nord orientale si stava preparando a sferrare un micidiale colpo contro le difese del mondo libero, forse un bombardamento nucleare tattico che preludeva sicuramente un’invasione.
Mesi o secoli dopo, seduto su un’auto che sfrecciava in un deserto africano, mi sarebbe venuto da pensare a lei in quei giorni come a una donna di Pompei che cerca invano di fare capire il pericolo rappresentato dalla fontana di fuoco che domina la città.
“Sei pronto? Dai usciamo, l’appuntamento è in università, ho sentito Mauro. Amore, ma hai realizzato?”
“Sì, Lena, cioè sì sono pronto, no non ho realizzato. Chi si è dato appuntamento in università, che cosa si fa?”
“Si prova a fermare la guerra. Dai usciamo. E’ stato indetto lo sciopero, Mauro mi ha fatto sapere che si trovano tutti alla Statale”.
“Da quanto tempo non usciamo assieme al mattino?”
“Da quando lavori nella tua amatissima azienda, che ti concede mezz’ora in più di sonno della sottoscritta”.
Lena insegnava, io non mi ero salvato dal fumo delle barricate, pur non essendo entrato in banca. Aveva varcato senza angosce il diffuso tabù dei quaranta. Era naturalmente bella, con occhi azzurri, capelli rossi, alta e senza un’ombra di trucco o di profumo. Non era stata nemmeno lontanamente sedotta dall’idea di rifarsi qualche parte del corpo e non aveva mai preso nemmeno in considerazione le sempre più diffuse guaineche ci avevano restituito un pezzo di diciottesimo secolo come quintessenza della post modernità. Non ricordo di averle mai sentito commentare il successo di queste prolifiche famiglie di mutandine e di reggiseni tra le sue amiche femministe. Tendeva, del resto, a disinteressarsi alle note di costume, ed evitava le polemiche che non le apparissero fondamentali o inevitabili. Come numerosi nostri coetanei figli del boom non avevamo figli e, in perfetta sintonia con la nostra generazione dello sboom demografico, non avevamo nemmeno in programma di farne.
Dai muri non trapelavano ancora le novità della notte. Grigi, o meglio, confusamente addobbati dalle incerte griffe di anonimi e narcisisti disagiati metropolitani, i muri avevano smesso di riflettere la politica. Se l’arte era diventata pubblicità, perché la street art non poteva trasformarsi in auto-promozione? Taggo, dunque sono. Osservavo i muri come non facevo da anni quando, davanti a un “CUCCIOLA CON TE FINO ALL’ETERNITA’”, Lena mi riportò nuovamente al mondo.
“Che cosa stai fissando? Dai che arriva il 98”. Le immobili facce del mattino, tuffate in uno smartphone, la sciarpa colorata di Lena per contrasto, mi facevano affiorare un’irresistibile voglia di baciarla appassionatamente, lì, tra la folla senza nome, ma con numero telefonico.
“Ehi, ma che ti prende? Abbiamo altri modi per farci denunciare oggi…”
“Perché, secondo te il giorno in cui scoppia una guerra qualcuno si mette a fare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico?”
“Non sottovalutare questo paese. Magari un cardinale ci sta riprendendo dal suo super attico”.
Scesi dal bus mi misi a osservare il guscio animalesco del marciapiede, con le sue fantasiose e recidive incrostazioni nere di piscio di cane, le bianche isole di chewing gumfossilizzato, i vari ed eventuali resti di imballaggi di generi di largo consumo, volantini commerciali, mozziconi, fazzoletti di carta usati, plastica di ogni tipo e ordine di riciclabilità. Milano ha dei marciapiedi osceni, formati da un puzzle di asfalti diversi: lavori perennemente in corso, appalti al massimo ribasso: ognuno apre e chiude e riasfalta il suo pezzettino.
“Raffaele, ci sei pure tu? Farai piovere!”.
“Mauro, stai arrivando adesso?”
“No, sono qui da un paio d’ore. La Statale è occupata, come un tempo, ma l’idea di fare un’assemblea prima di andare in Duomo è saltata: siamo semplicemente in troppi. Ciao Lena, io corro in avanti che mi stanno aspettando”.
Camminavamo rapidamente per via Bergamini, io mi sentivo ansioso di scoprire che cosa stesse succedendo, come quel mattino del 1986, quando scorsi per la prima volta una bandiera rossa sventolare da un balcone dell’università. Allora c’era l’entusiasmo di chi non vede l’ora di prendere parte a un qualcosa che altri avevano vissuto alcuni anni prima, di raccoglierne le bandiere. Ora provavo la stupita curiosità di chi le bandiere le ha viste cadere, una dopo l’altra, senza poterle passare a nessuno.
Il vento freddo che scivolava sulla stessa via, in direzione opposta, ci faceva camminare sempre più stretti l’uno contro l’altra.
Non era l’occupazione che avevo conosciuto, non quella delle bandiere rosse, e neppure quella dei graffiti, delle canne, del rap e della lambada che era arrivata poi con la Pantera. L’immancabile camion di qualche centro sociale, con le sue casse e la sua musica techno-riot, rebel-tunz o chissà che cos’altro, era molto defilato. Lo sciame umano si stendeva per i corridoi, colonizzava il prato, fluiva sotto i portici, occupava aule, saliva e scendeva scale, recuperando estintori, fotocopiando volantini, attaccando striscioni. Fluiva, quasi volava, in frenetica attesa di muoversi verso la piazza, di bloccare la città e con essa paralizzare la guerra. Gli organizzatori, se così si potevano chiamare, comunicavano col cellulare, usando un’app a me ignota, che si chiama Zello, e pareva avessero tutti delle vecchissime ricetrasmittenti. Le ricetrasmittenti erano vietate, Zello no, anche se sicuramente intercettato.
Fulvia ci stava chiamando. Che bello vedervi, anche voi qui, che cosa succede, sapete nulla: frasi che avremmo pronunciato e ascoltato per tutta la giornata, sospesa tra l’ansia e la felicità pubblica, la paura e la voglia di fare.
“Se ci perdiamo ci si trova in università. Dai, dammelo adesso il bacio dell’autobus. Perché quella faccia? Guarda che non andiamo mica al macello. Oggi non succederà nulla, ci fanno sfogare.”
Nel centro di Milano si faticava a muoversi. Piazza Duomo era ormai inaccessibile, le vie limitrofe si andavano riempiendo. A ondate arrivavano le scuole, coi loro striscioni, le Rsu degli uffici pubblici e di qualche grande azienda privata, ma anche tanti lavoratori che, alla spicciolata, scendevano dai grandi alveari degli uffici, salivano dalle stazioni della metropolitana. Lena aveva ragione: ci lasciavano sfogare. La polizia era nascosta, presidiava giusto qualche obiettivo sensibile. Uno stato fascista non tollera nemmeno una manifestazione di protesta, uno stato democratico ne può tollerare diverse, purché non servano a nulla.
I cortei, interrotti da comizi volanti, presidi, soste, durarono per tutta la giornata.
A sera, in attesa dell’assemblea, riposavo sfinito su una sedia dell’aula magna, dopo una giornata passata all’aperto e quasi sempre in movimento, e mi affiorava alla mente il sogno della mattina. Chi erano i misteriosi invasori? Chi stava effettivamente combattendo? Sembrava di essersi svegliati in una storia dell’Eternauta.
“Raffaele…?”. “La concha de la lora, Tania!”.
“Incredibile…Credo di averti conosciuto proprio su questa sedia”.
“Beh, detta così sembra molto più allettante di com’è stato in realtà”.
“Scemo, volevo dire che mi ricordo che ci siamo conosciuti commentando gli interventi di un’assemblea dell’occupazione…chissà che anno era…che hai? Sei stanco? Ma da dove salti fuori? Non so più nemmeno che lavoro fai”.
“E’ da stamattina che sono in giro, non ho mangiato, l’età si fa sentire. Lavoro alla Tkbv, se non lo sapevi significa che non ci vediamo da almeno vent’anni. Un’onesta routine da impiegato senza concetto. Non ho fatto carriera, ma certo non perché abbia scelto la politica, né perché abbia rotto i coglioni in azienda. Ho sempre avuto chiaro che un quadro non fosse altro che uno scemo che non ha orari, né straordinari, che si trova a spremere i subalterni, oppure ad accollarsi pure il loro lavoro, il tutto per ingrassare dirigenti, consulenti e padroni”.
“Hai sempre il dono della sintesi, vecchio. E hai continuato a fare politica?”
“No, pochi anni dopo essermi sposato con Lena ho smesso di fare politica. Lei ha continuato, è stata la mia finestra sul mondo, mentre io credo di essermi limitato a sonnecchiare…”
“In questi anni di merda. La conosco? Lena, intendo.”
“No, lei studiava a Pisa. Poi te la presento, adesso non so dove sia finita. Staranno preparando l’assemblea, tra un’ora dovrebbe iniziare. “
Non ero mai intervenuto in un’assemblea, ma nei primi anni di università mi appassionavo ascoltando gli interventi di chi era più determinato di me. Applaudivo chi mi sembrava più convincente, a volte trovavo pure qualcuno in grado di esprimere con chiarezza quel che io pensavo confusamente. Poi approdai a uno stadio successivo: iniziai a capire chi diceva che cosa e perché, chi stava con chi. Realizzai che una proposta giusta poteva essere sbagliata, che una proposta democratica poteva essere antidemocratica, e viceversa. Compresi che la politica non è né sporca, né pulita, ma non è neppure ingenua. Mi appassionavo diversamente da prima, però mi appassionavo ancora. Avevo lo sguardo distaccato dell’addetto ai lavori, che sa che cosa sta succedendo, e quel che ancora ignora sa come venirlo a sapere.
Tania, soprannominata callipigia dall’unico che aveva fatto il classico, e con molto meno poetiche varianti dagli altri, piaceva a tutti i ragazzi della facoltà. La sua caratteristica, all’epoca, era di comparire e scomparire dal nulla, come un’oscillazione o, per i meno scientifici, come un fantasma. Poteva eclissarsi per mesi e poi arrivare silenziosamente al tuo fianco e chiederti di accenderle una sigaretta, come se fosse stata via cinque minuti al bagno. Gli uomini che magari, dopo mesi di spasmodica attesa, avevano il merito o la fortuna di passare una notte con lei, vivevano spesso queste sparizioni con angoscia.
“Perché hai smesso di fare politica? Ti pensavo uno dei tanti accomodati al calduccio nel sistema”. Poi, con un mezzo sorriso aggiunse: “Nemmeno io sono stata molto costante”, mentre sfregava nervosamente il lembo della giacca di pelle.
“Ho smesso quando ho capito che potevano andare avanti malissimo anche senza di me…mi son sentito parte di un lento suicidio dei coglioni. Non avevo le capacità di portare avanti qualcosa di diverso, non sono mai stato un dirigente, né pretendevo di esserlo. Non ero così cieco da non accorgermi della deriva, da non vedere la corsa alla poltrona da un lato, la stanca ripetizione dall’altro. E poi mi sembrava che anche negli ambienti più sinceri la politica contasse sempre meno e la psicologia sempre di più: ci si trovava di fronte una schiera crescente di narcisisti patologici, individualisti, psicolabili. E tu?”
“Ho avuto due figli, da due uomini diversi. Sono sempre stata precaria. Nulla di originale. Forse militavo in ambienti più divertenti dei tuoi. Più creativi e ricreativi, ma certo non più concreti. Magari non c’erano poltrone da occupare, ma diversi ego da soddisfare sì. Dai che si inizia.”
Ritornai a casa con la convinzione di avere vissuto il giorno più lungo della mia vita. Era incominciato sognando un’invasione aliena, per realizzare immediatamente dopo di trovarmi in una guerra reale. Questa realtà mi aveva introdotto in un tunnel temporale con uscita davanti a quella Statale che avevo iniziato a frequentare quando ancora era normale vedervi delle bandiere rosse sventolare fuori dai balconi. Dopo un lunghissimo corteo avevo concluso la giornata in un’assemblea, che aveva cancellato il pessimo ricordo di tante sempre più inutili degli ultimi anni. Ma quando ero andato in bagno l’ultima volta?
“Lena, sbrighiamoci che sto per farmela addosso”.
La sveglia del giorno seguente era stata meno burrascosa. Avevo dormito profondamente, ma in un latente stato di agitazione, camminando fra gli scheletri di enormi palazzi di un quartiere di nuova e inutile urbanizzazione. Un cantiere fantasma, costellato di muri incompleti, balconi vuoti, pozzanghere e betoniere. Improvvisamente mi ritrovavo a brancolare all’interno di una casa vecchia, in penombra, i mobili coperti da lunghi teli bianchi e ragnatele. Avrei dovuto dormire lì, trovare la mia stanza, scoprire il letto, le poltrone. Nessuno me lo impediva, ma io non provavo neppure a cercare nei cassetti, dove magari avrei potuto trovare una lampada. Passavano i giorni, non potevo uscire, evitavo i sotterranei e alcune stanze. Facevo il meno possibile, evitavo anche di scoprire i mobili dai teli che li ricoprivano, provavo una sensazione di pigrizia mista a terrore paralizzante. I giorni trascorrevano uguali a se stessi in quella sorta di casa prigione, apparentemente priva di carcerieri e di sbarre. Ciondolavo ogni giorno più pigro nella mia stanza, con sempre meno iniziativa, e sempre più consapevole di una misteriosa e terribile una presenza in casa che, per ora, non si manifestava.
Al mattino, a tavola, trovai una sorta di banchetto: una colazione di altri tempi.
“Hai visto che ieri ci hanno lasciato fare? Secondo me oggi sarà ancora così. Ma da domani, o dopo, inizieranno a colpire”, disse Lena con un cucchiaino di marmellata in bocca e seduta con un piede sotto il sedere.
“Che cosa pensi che faranno? Che cosa vi siete detti dopo l’assemblea? Ieri non mi aspettavo nulla. Pensavo che ci sarebbero state le solite risse verbali, i soliloqui, le provocazioni, i pompieraggi”.
“Perché sei sempre prevenuto.”
“A ragione, direi. Comunque, telo concedo, anche se non si è deciso nulla, il clima è cambiato da quel che mi ricordavo. Se non altro gli interventi sono più concreti e consapevoli degli ultimi che avevo sentito anni fa.””
“Per quanto ti riguarda secoli fa”.
“Ma ti ricordi di quelli che volevano, con poche centinaia di persone, bloccare al mattino tutte le vie d’accesso alla città? E degli altri che inscenavano la guerriglia solo dopo aver concordato tutto con la polizia e caricando i video della loro azione su facebook immediatamente dopo?”
“Sì, per non parlare di quelli che pensavano di risolvere tutto con teatro di strada, flash mob e aperitivi. I compagni pensano che il parlamento voterà a breve i crediti di guerra…mi sembra di uscire da un libro di storia, anche se qui non c’è più nessun partito che possa tradire inaspettatamente: il tradimento è esattamente quello che tutti si aspettano”. Aggiunse dopo un istante, come ragionando a voce alta: “Da quel momento in poi non sarà più permessa alcuna opposizione. La propaganda sarà feroce e opprimente. Fino a quando sarà possibile manifesteremo e cercheremo di fare manifestazioni sempre più grandi, anche per spingere i sindacati a proclamare nuovi scioperi. Dovremo fare il giro delle nostre amicizie, contattare tutti, spiegare che cosa sta succedendo e che cosa succederà, portarli in piazza.”
“E poi?”
“E poi si resisterà…sabotando, boicottando. Una cosa che mi ha stupito è che improvvisamente sono tutti favorevoli all’organizzazione. Nessuno ha più voglia di immolarsi, o di immolare gli altri, sull’altare dello spontaneismo.”
“Nessuno? E chi ha trasformato l’acqua in vino?”
“Rettifico: nessuno di quelli con cui ho parlato. Degli altri vedremo come occuparcene.”
Quando era concentrata sulla politica avrebbe potuto non accorgersi di un petardo che esplode sotto il letto dove nel frattempo eravamo tornati, o più modestamente del lungo tragitto delle mie dita. Se ne rese conto solo dopo un po’, glielo vidi esplodere in faccia, poi mi cacciò sotto il piumino e non vidi più nulla.
“Siamo in ritardissimo. Dai, corri, dovremmo già essere in università”.
Da un gigantesco manifesto, alto tre piani di un edificio, una gigante sottopeso, in mutande e reggiseno, con sguardo invitante e aria da adolescente, pubblicizzava l’intimo Maidiremay. Mi chiedevo se il messaggio fosse principalmente rivolto alle donne, agli uomini, o a entrambi.
L’università brulicava di energie, persone di ogni tipo comunque indaffarate. Le riunioni si susseguivano: commissioni organizzative, commissione comunicazione, commissione politica, riunione plenaria. Sui muri i vari elenchi delle iniziative, contraddittori l’uno con l’altro. Si usciva per manifestare, per fare un blocco stradale, si rientrava per una conferenza stampa. Le lezioni erano sospese, gli esami pure, compresi quelli di laurea. Sporadiche proteste venivano subito zittite: chi con una guerra in corso pensava a laurearsi era chiamato “dottore del buco del cul”, alludendo allo stupido coretto goliardico che immancabilmente, ritualmente risuonava dopo ogni laurea. “Tanto, se va avanti così, finirai al fronte, che te ne fai della laurea?”, domandava ai malcapitati chi aveva più propensione al dialogo. Qualche professore si degnava di partecipare alle assemblee, pochissimi davano il loro contributo nei seminari autogestiti sulla politica internazionale, i nuovi armamenti, la sospensione dello stato di diritto.